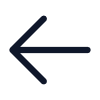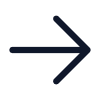Roy Andersson

source:mardelplatafilmfestcom
La nueva película de Roy Andersson, una especie de secuela espiritual de A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, está compuesta por una serie de viñetas narradas por una mujer joven desde un futuro indefinido: una pareja flota por una Colonia en ruinas; un padre se detiene a atar los cordones de los zapatos de su hija bajo la lluvia; un cura con crisis de fe busca ayuda de un psiquiatra que lo único que quiere es llegar a tomar el colectivo de vuelta a casa. La película, por la que Andersson ganó el León de Plata a Mejor Director en el último Festival de Venecia, es otra muestra de su talento para captar la esencia de la vida, transitando entre la comedia y el drama, entre la alegría y la tristeza. Y todo esto en apenas 76 encantadores minutos.
Roy Andersson
Nació en Gotemburgo, Suecia, en 1943. En 1969, se graduó de la Escuela de Cine de Suecia, y al año siguiente su ópera prima A Swedish Love Story ganó cuatro premios en el Festival de Berlín. En 2009, el MoMA hizo una muestra de su trabajo.
.
.
.
.
.
.
.
source:domuswebit
Despite its exasperating slowness, the public (and the jury) welcomed him with great affection at the latest Venice Film Festival. Swedish director Roy Andersson’s latest film collects fragments of Nordic everyday life, accentuating the protagonists’ inactivity and the grotesque hidden potentially everywhere. A woman whose heel is broken decides to walk barefoot at the station, a priest who loses his faith talks to his psychoanalyst, a dentist gets sick of his patient’s paranoia, a waiter is distracted while pouring wine, an old couple comments on the climate, and so on.
The direction doesn’t add anything new to his cult films, at a point that among the audience there were those who claimed that the scenes were remnants of A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014) or Songs from the Second Floor (2000). All the scenes open up as motionless as oil paintings, an effect accentuated by the artificial pallor of the actors, the director’s hallmark. The narrator’s voice is feminine and crystalline, and opens all the chapters with the phrase “I saw a man/woman who…”: you can hear it a sufficient number of times to learn it in Swedish.
The phlegmatic rhythm makes tangible the powerful inner turmoil of the protagonists, who only on rare occasions vent them but, you can guess, never to the end. The set design plays on a contemporary vintage made of modern furniture and pastel colors, uniformed by a very bright light that metaphorically dissolves every accent. The surfaces are treated with textures that give a patina of past times, even when the furniture looks just like Ikea.
About Endlessness is one of the few fictional films that participated to the Venetian festival, loaded, instead, with excellent documentaries and socially denouncing films. The fact that it won alongside Joker (Golden Lion, by Todd Phillips) and J’Accuse (Silver Lion, by Roman Polanski) – both fiction movies – tells us that the public and the jury are very keen to return to using cinema as a means of dreaming.
.
.
.
.
.
.
.
source:sentieriselvaggiit
Roy Andersson è sempre Roy Andersson che riflette sulla nostra esistenza, tema che lo affascina e al tempo stesso lo diverte. Un film a suo modo infinito questo Om det oändliga che poi sarebbe a dire Sull’infinito. Un racconto per haiku, a volte fulminanti e ironici, a volte malinconici e in altre occasioni terribilmente desolanti. Eserciti sconfitti che marciano sotto la neve, dentisti stufi dei loro clienti paurosi e doloranti, uomini depressi che fanno i conti con la vita comparandola con quelli dei più fortunati, ma incapaci, ex compagni di scuola, preti che hanno perduto la fede e si rivolgono allo psicanalista o ragazze che semplicemente ballano fuori da un locale. Andersson mette in scena la sua personale visione della vita con le sue banalità e i suoi momenti assolutamente insignificanti che però meritano di essere ricordati o forse non lo meritano, ma vanno ricordati lo stesso per una specie di romanticismo del quotidiano. Una voce fuori campo ci accompagna in questo infinito viaggio dentro una semplice umanità, è la voce di una donna, onnipresente e onnisciente che inizia ogni suo breve racconto con le parole Ho visto un uomo…. E’ una testimone che ha sempre vissuto, o forse è una specie di coscienza collettiva o come suggerisce qualcuno una nuova Sherazade che anima le nostre notti con l’intermezzo di questi racconti. Andersson procede con i suoi tableau vivant e con la sua fotografia iperrealista nel virato seppia, continua a riflettere sulla bellezza dell’esistenza e per farlo, spiega nelle sue note di regia, ha bisogno di evidenziare la parte meno bella della vita, la parte peggiore. I miti greci, come egli stesso aggiunge, gli hanno ispirato le scene e il film è una specie di infinita cornucopia dalla altrettanto illimitata inesauribilità.
La freddezza nordica di Roy Andersson è per qualche verso simile a quella altrettanto compassata, ma più calda di Otar Iosseliani e tra i due autori corre un filo di affinità che si rivela nello sguardo ironico, ma sempre benevolo sull’umanità. Ma la dove i personaggi del regista georgiano sono vitali dentro la scena, Andersson sostituisce alla vitalità, una assoluta fissità di fondo da teatro dell’assurdo, un palcoscenico angusto dentro il quale si muovono. Om det oändliga non si discosta da questa caratteristica e la messa in scena è costruita sulla assenza di relazione tra i personaggi, su una loro altrettanto immobile contemplazione degli eventi.
Qui il discorso sul cinema di Andersson si fa più complicato, più complesso è, infatti, mettere insieme, conciliare le intenzioni che lo stesso autore ha riaffermato con una soluzione scenica di assoluta freddezza, privata di ogni energia vitale. Temiamo che l’ottimismo di Roy Andersson abbia a che fare, invece, con un pessimismo latente che non è infrequente negli autori del nord-europa e che il cinema diventi una specie di utile lenitivo o forse un alibi intellettuale per un innato e difficilmente guaribile scetticismo con cui, nonostante i dichiarati entusiasmi per l’umanità, si continui a guardare la vita. La sua fotografia quasi bruegeliana, la perfezione sempre simmetrica della sua macchina da presa (anche quando non lo è, questa è l’impressione), la luce anodina che pervade l’immagine, lo scenario essenziale e sempre curatissimo, l’iperrealismo che diventa il risultato di questa ricerca visiva e soprattutto l’uso costante, marchio di fabbrica, di colori smorti e quasi da animazione digitale, ricompongono una visione surreale del mondo e i brevi racconti del film diventano vere e proprie cartoline surrealiste in cui la combinazione della veglia e del sogno sembrano fondersi in una terza dimensione che non appartiene a nessuna delle due origini, ma ne costituisce l’ideale soluzione. Veglia e sogno in una realtà aumentata che nulla ha di reale, ma poco di irreale, è la terza dimensione del regista svedese, quella in cui egli sembra vivere e guardare distaccato e scettico l’agitarsi del mondo.
Se queste caratteristiche hanno un senso, si ravviva l’idea che Andersson giochi un poco con il pubblico e offra un’immagine deformata delle sue vere intenzioni, ammantate di un (difficile) ottimismo e carico, in realtà, di un ricercato e vivido pessimismo che forse, portato alle estreme conseguenze, riconduce ad una carsica visione fiduciosa dell’esistenza. Solo così possono conciliarsi le parole del regista e le immagini del film.
Il lavoro Andersson è sempre stato personalissimo e non è casuale che il suo silenzio artistico si sia prolungato per tanti anni e che i suoi film nascano non dettati dalle solite logiche produttive, ma da esigenze del tutto proprie dell’autore. Siamo altrettanto convinti che l’apparente semplicità della costruzione, tradisca, come sempre accade, la complessa elaborazione che sta alle spalle. Ma tutto questo non fa che complicare ancora di più le cose.
Ci accorgiamo della ricercatezza di questo cinema e ne scorgiamo anche i profili di interesse che contiene, e bene si comprende, che il lavoro intellettuale che lo ha creato costituisce il vero motivo di interesse del regista, ma se il cinema è anche imperfezione vitale, salgono le quotazioni dei dubbi che possono essere nutriti sul film (e anche sui precedenti non dissimili). Roy Andersson lavora su una contemplazione della vita che si fa distante, su una ricerca che sublima ogni possibile efficacia epifanica della composizione, in questo senso i suoi haiku visivi sono sicuramente divertenti e fulminanti, ma sembra essere quasi del tutto assente l’alito vitale che serve a scambiare sentimento, non solo con il pubblico, ma con un ideale interlocutore. Il cinema di Roy Andersson resta contemplativo e in questo perfino pregevole, lineare, perfetto, come certi mobili di design, ma talvolta non si vede l’ora di vedere un po’ di sporco sullo schermo, sperando che qualche schizzo arrivi anche in sala.