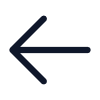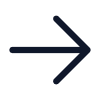DAVID BOWEN
SPACEJUNK

source: dwbowen
The 50 twigs in this installation point in unison in the direction of the oldest piece of human made space debris currently above the horizon. The debris being tracked are spent rocket bodies, parts from defunct satellites and wayward tools launched in missions as far back as 1958. When the piece of debris being tracked drops below the installation’s horizon the twigs go to a rested downward pointing position and await the next debris to appear. The composition is continually changing as it tracks the oldest discarded objects orbiting the earth that enter its point of view.
.
.
.
.
.
.
.
source: digicultit
Watching David Bowen’s Spacejunk, you can’t help but feel a certain religious piety has formed in the gallery space. The 50 twigs, controlled by servo motors and mounted on thin but tall metal plinths, raise their arms in supplication, as space debris rises above the horizon. The arms trace the movement of the debris – unseen by the gallery visitor – and lower again when it has passed. But of course, technology is the new religion and God is dead. And if that’s so, Spacejunk comes across a sculptural re-enactment of the Myth of Sisyphus, with Albert Camus’ interpretation of the myth offering us an inroad to understand David Bowen’s installation.
These 50 disciples feel as though they’re honouring the detritus of our attempts to reach out into space. In following the objects (tracked live via data supplied from a website) there is a fetishing of unseen forces at work in the installation, looking to bring back to our immediate, physical awareness the golden totems of past space race glories, going back as far as 1958. Every launch into Earth orbit is in some way a failure, because it reminds us that we’re still at the mercy of our faltering, (cosmically) youthful inability to master interstellar travel. Even geostationary orbits, for GPS and communications merely reflect our earthbound lives back to us. We rise up and fall back down, ignorant of what previous attempts at space travel should have made us realise by now: we aren’t ready to shake of the bond of human to planet.
The twigs fall, or rather, lower themselves into standby mode, when the tracked debris goes below the horizon. When it happens suddenly, it’s like the shrug of acceptance of the congregation, faced with the reality of their situation. For us it’s the acceptance that our technology will only ever be as good as it is at the present stage. Not a contradiction, but a realisation that we’re a confined within a moment of existence, with only the past trailing a path backwards, so we can see how far we’ve come.
Spacejunk tracks, literally as well as figuratively, that path for us. And there’s everything in the debris, including frozen urine, ejected from spacecraft, to a spatula and an astronaut’s glove. These feel absurd but reveal the truth in space travel: that we take ourselves and our puny human flesh with us. Bowen himself sees the creation of this loose cloud of debris: “like we’ve created our own extra layer of the atmosphere out there. I see it as an extension of the anthropocene. I’m wondering when these objects start to become natural objects. It’s something I think about with the work.”
With the steady build up of objects over the decades, and the increasing amount of things we’re putting out into space, these anthropocenic objects are being tracked for safety reasons. The 2013 movie Gravity, envisioned a potential Kessler Syndrome: when a low earth orbital collision creates enough debris to create larger collisions and increases in a domino effect. As Bowen observed in our recent Skype interview: “Tremendous amounts of energy were expended to put [these objects] up there. Vanguard 1, for example, is still up there. They’ll be up there for millions of years because their orbit is not going to decay!”
Perhaps, as part of their worship, the twigs want the objects to return to their natural state? Everything is made from the elements of the universe, so why not have them return to their elemental parts? As David says: “Are [these objects] ‘naturally’ orbiting? When do they become natural objects again?” And there’s the aspect of decay of course, just like natural objects. They will eventually return their energy to the Earth, in one form or another, mostly burning up on re-entry.
Bowen has a wry interest in the absurd that a casual observer might not immediately see in the work. The tracked objects included a spatula, glove, and of course, chunks of urine. The idea that some of the objects tracked might be human piss, reminds us that despite our poetic narratives of space travel, we’re still organic, natural matter. This organic, natural form is evident in other works of Bowen’s (such as FlyAI and Fly Revolver), where flies become part of the work and often act as a computing device within the project.
There’s a breaking of the usual relationship between the gallery visitor and the art work in pieces like Spacejunk, where a kind of action at a distance, mediated by technology but invisible to the viewer is taking place. The work is influenced by events taking place beyond the gallery space. Bowen establishes this broader relationship of viewer, art work, physical location as a key aspect of the work. “Wherever the work is installed, that horizon is going to be different.”
There’s not a constant repetition of the behaviour: it changes depending on location. The data is harvested from websites that make the tracking data available and fed to the servo motors, but the work has an awareness of where is and the data changes accordingly. These changes are visible in the low arcs or high pointing movements of the twigs. The twigs quiver as the precise brushes of the servo motors work away to control and point the debris. “There’s a collective jerk as they align.”
David Bowen touches on data visualisations when he talks about the work, but really it’s just using contemporary idioms, there’s no scientific activity meant by the work. For him, its value is in the poetic. Bowen comes from a sculptural background, so the physicality is part of the work, and really on the scale of the localised space, they’re not far apart at all. Bringing the distant, on to a human level. The twig as an arm, gesturing.
In The Myth of Sisyphus, Camus posits that, by facing the eternal struggle of our lives, and finding some contentment with it, we can find the existential freedom to live on. Spacejunk is a reminder that humanity has decided to begin the struggle to climb above Earth’s surface taking much of our detritus with us: which is part of that struggle, of course, being not just one of overcoming physics, but our own intellectual limitations. Instead of being an homage to the failures though, Spacejunk reminds us that although we constantly fail, we always rise up and try again.
.
.
.
.
.
.
.
source: digicultit
Davanti a Spacejunk di David Bowen, non si può fare a meno di percepire una forma di pietà religiosa che ha preso forma nello spazio espositivo. I 50 ramoscelli, controllati da servo motori e montati su alti e sottili piedistalli metallici, alzano le braccia come in un atto di supplica, a mano a mano che rifiuti spaziali si sollevano sopra l’orizzonte. Le braccia disegnano i movimenti dei detriti – invisibili ai visitatori della galleria – e si abbassano di nuovo al loro passaggio. Ma ovviamente, la tecnologia è la nuova religione e Dio è morto. E dunque, Spacejunk si presenta come una rievocazione plastica del Mito di Sisifo, ed è l’interpretazione di tale mito di Albert Camus che offre una chiave di lettura per l’istallazione di David Bowen.
Questi 50 discepoli sembrano onorare i detriti dei nostri tentativi di raggiungere lo spazio. Nel seguire gli oggetti (tracciati in tempo reale attraverso dati forniti da un sito internet) c’è un’idolatria di forze invisibili al lavoro di installazione, che vogliono riportare alla nostra coscienza fisica e immediata gli emblemi dorati delle glorie passate della corsa allo spazio, a partire sin dal 1958. Ogni lancio nell’orbita terrestre è, in un certo senso, un fallimento, perché ci ricorda che siamo ancora alla mercé della nostra incapacità, incerta e (cosmicamente) giovane, di padroneggiare il viaggio interstellare. Anche le orbite geostazionarie, per i satelliti GPS e di comunicazione, si limitano a ricordarci la nostra natura terrestre. Ci alziamo e ricadiamo, ignorando la lezione che avrebbero dovuto insegnarci i precedenti tentativi di viaggio nello spazio: non siamo pronti a liberarci del legame tra umanità e pianeta.
I ramoscelli cadono, o meglio, si abbassano in attesa, quando i detriti rintracciati scendono sotto l’orizzonte. Quando succede improvvisamente, è come un’alzata di spalle di accettazione della collettività, davanti alla realtà della loro situazione. Per noi invece è la rassegnazione che la nostra tecnologia sarà sempre soltanto buona così come lo è adesso. Non è una contraddizione, ma è la consapevolezza che siamo limitati in un momento preciso della nostra esistenza e che il passato segue il cammino così da mostrarci quanta strada abbiamo fatto finora.
Spacejunk traccia, letteralmente e figurativamente, quella strada per noi. Tra i detriti si trova di tutto, inclusa urina congelata, espulsa dal veicolo spaziale, una spatola e un guanto da astronauta. Tutto ciò sembra assurdo, ma rivela la verità sui viaggi nello spazio: che portiamo noi stessi e la nostra debole carne umana con noi. Bowen stesso vede la creazione di questa nuvola rarefatta di detriti: “come se là fuori avessimo creato il nostro strato extra di atmosfera. La vedo come un’estensione dell’Antropocene. Mi domando quando questi oggetti diventeranno naturali. È qualcosa a cui penso mentre lavoro.”
Con il costante accumulo di oggetti nei decenni e la crescente quantità di cose che rilasciamo nello spazio, questi oggetti antropocenici sono monitorati per questioni di sicurezza. In Gravity, film del 2013, s’immaginava una potenziale Sindrome di Kessler: quando una collisione a una bassa orbita terrestre crea sufficienti detriti in grado di produrre collisioni ancora più grandi che aumentano poi in un effetto domino. Come ha osservato Bowen nella nostra recente intervista su Skype: “Enormi quantità di energia sono state spese per rilasciare [questi oggetti]. Vanguard 1, ad esempio, è ancora lì. Vi rimarranno per milioni di anni perché la loro orbita non decadrà!”
Forse, come parte della loro adorazione, i ramoscelli vogliono che gli oggetti ritornino al loro stato naturale? Ogni cosa è fatta degli elementi dell’universo, così perché non fare sì che ritornino alle loro parti elementali? Come dice ancora David: “[Questi oggetti] stanno orbitando ‘naturalmente’? Quando diventeranno nuovamente oggetti naturali?” Certamente c’è anche l’aspetto del decadimento, proprio come gli oggetti naturali. Alla fine restituiranno la loro energia alla Terra, in una forma o nell’altra, principalmente bruciando durante il rientro.
Bowen ha un interesse ironico nell’assurdo, che un osservatore casuale potrebbe non vedere immediatamente nell’opera. Gli oggetti tracciati includevano una spatola, un guanto e, naturalmente, pezzi di urina. L’idea che alcuni degli oggetti tracciati possano essere pipì umana, ci ricorda che nonostante le nostre poetiche narrazioni dei viaggi nello spazio, siamo pur sempre materia organica naturale. Questa forma organica, naturale, è evidente nelle altre opere di Bowen (come FlyAI e Fly Revolver) dove le mosche diventano parte dell’opera e spesso agiscono come un dispositivo calcolatore all’interno del progetto.
C’è una rottura nella tradizionale relazione tra il visitatore della galleria e l’opera d’arte in pezzi come Spacejunk, dove ha luogo un tipo di azione a distanza, mediato dalla tecnologia ma invisibile all’osservatore. L’opera è influenzata dagli eventi che hanno luogo oltre lo spazio della galleria. Bowen stabilisce questa più ampia relazione con osservatore, opera d’arte, luogo fisico come un aspetto chiave del lavoro. “Dove l’opera è installata, quell’orizzonte sarà differente”.
Non esiste una ripetizione costante del comportamento: cambia a seconda della posizione. I dati vengono raccolti da siti web che li rendono disponibili e li inviano ai servomotori, ma l’opera ha una consapevolezza di dove si trova e i dati cambiano di conseguenza. Questi cambiamenti sono visibili negli archi bassi o nei movimenti verso l’alto dei rami. I rami fremono nello stesso modo in cui i pennelli precisi dei servomotori lavorano per controllare e indicare i detriti. “C’è un sobbalzo collettivo quando si allineano.”
David Bowen accenna alle visualizzazioni dei dati quando parla dell’opera, ma in realtà usa solo espressioni contemporanee, non esiste un’attività scientifica intesa dall’opera. Per lui, il suo valore è nella poetica. Bowen ha un passato da scultore, quindi la fisicità fa parte del lavoro e, in realtà, sulla scala dello spazio localizzato, non sono affatto distanti. Portare il lontano ad un livello umano. Il ramoscello che diventa un braccio che si muove.
Nel Mito di Sisifo, Camus afferma che, affrontando la lotta eterna della nostra vita e trovando in essa qualche soddisfazione, possiamo trovare la libertà esistenziale per vivere. Spacejunk vuole ricordarci che l’umanità ha iniziato a sforzarsi di scalare la superficie terrestre, portando con noi gran parte dei nostri detriti: tutto ciò fa parte dello sforzo di non superare solamente la fisica, ma anche le nostre limitazioni intellettuali. Invece di essere un omaggio ai fallimenti, Spacejunk ci ricorda che, anche se continuiamo a fallire, ci rialziamo e ci riproviamo sempre.